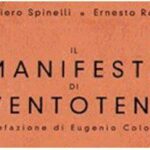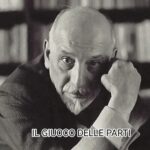Aerofoni e serbatoio d’aria

di Giuseppe Moesch-*
Non credo sia necessario evocare Marcel Proust per suggerire come alcune immagini, suoni, profumi, facciano esplodere in noi il ricordo e le memorie dal passato e ci riportino indietro nel tempo ad evocare sentimenti più o meno latenti. Per me, ma credo per molti, il lamentoso suono di ciaramelle e zampogne che ancora si sentono in queste giornate d’avvento per le vie delle città, ma più spesso nei punti di aggregazione, le nuove piazze, che sono diventate i centri commerciali, suscitino un facile richiamo all’infanzia e alle suggestioni che dava il Natale.
I primi tentativi di articolazione di un linguaggio tra gli ominidi furono espressi, quasi sicuramente, attraverso rumori più o meno articolati ma quasi certamente accompagnati da suoni ottenuti con un qualche strumento musicale primordiale.
I bambini istintivamente percuotono gli oggetti che hanno a disposizione battendoli su altre superfici, e normalmente tendono a portare alla bocca ogni cosa che gli capiti a tiro, per sentirne sapore e consistenza e soffiano l’aria dai loro polmoni producendo sonorità che se passano attraverso un amplificatore generano suoni più o meno gradevoli.
L’evoluzione di quei messaggi primordiali genera facilmente i primi strumenti a percussione e quelli a fiato, che insieme al tintinnio di pezzi di pietra sono le prime forme musicali esistite.
Il bisogno di amplificare quei suoni porta ad utilizzare alcuni oggetti come ad esempio le grosse conchiglie tortili, le buccine, trovate in gran copia nei vari siti archeologici, che permettevano di far sentire il loro suono a grandi distanze; tra questi un antico reperto è stato ritrovato nella grotta di Marsoulas in Francia, per capirci in quella nella quale appaiono le famose pitture rupestri del bisonte di Higgs, e risale ad oltre 18000 anni fa. Si ipotizza che a quella Charonia lampas, questo il nome del mollusco che già da allora viveva nel Mediterraneo presso le coste francesi, fosse applicato un bocchino formato forse da un osso di uccello, e con il quale un esperto suonatore di corno sia riuscito a riprodurre tre note, Do, Re e Do diesis.
Altri oggetti come ad esempio le canne forate possono generare suoni più o meno acuti e modulabili dando vita alle prime forme di flauti, utilizzati nelle società agro pastorali; è normale infatti, che in tutte le religioni primordiali le divinità siano legate ai fenomeni naturali e praticamente in tutte si ritrova un dio dei boschi e delle selve: presso i popoli mesopotamici ed i sumeri in particolare c’è il dio Enkidu, per i greci il dio Pan, per i latini Sileno a cui si accompagnano ninfe o altre forme divine femminili che rappresentano la gioia della natura selvaggia e pura, che si accoppiano gioiosamente accompagnate dalla musica e spesso prese dall’ebbrezza del vino.
Il flauto fu un tipico strumento suonato dai pastori nelle lunghe ore di solitudine; ci si accorse subito che il suono delle canne non era sempre uguale, ma dipendeva dalla lunghezza delle stesse per cui cominciarono ad essere affiancate due o più canne per ottenere più suoni allo stesso tempo.
Legando assieme cinque o sette o dodici canne di differente lunghezza si poteva così modulare il suono e nacque quello che si chiamò “siringa” o flauto di Pan, con riferimento alla divinità greca delle selve e dei boschi.

Ovidio racconta nelle Metamorfosi la storia di Pan, figlio di Ermes (qualcuno dice dello stesso Zeus) e della ninfa Driope (per alcuni Penelope, non la moglie di Ulisse bensì una ninfa), racconto accreditato da Apollodoro e Pausania.
Si dice che Pan fosse brutto e con forme metà umana e metà caprina, che fu abbandonato dalla madre; il padre lo condusse sull’Olimpo dove fu ben accolto. Simbolo della mascolinità rude e manifesta, grande tombeur di ninfe che apprezzava particolarmente e che quasi sempre ricambiavano, compagno di bisboccia di Dioniso, si invaghì di Siringa non ricambiato, figlia di Ladone, una divinità fluviale. La fanciulla inseguita dal dio, implorò il padre di salvarla dall’assatanato potenziale stupratore, e giunta sulle rive del fiume fu tramutata, al cospetto di Pan, in canne.
Le articolazioni mutate in nodi e i capelli in foglie che al vento gemevano con suono dolce e triste, indussero Il povero Pan a stringere a sé quel che restava dell’amata. Strappò alcune di quelle canne di diversa lunghezza, le unì con la cera a ricomporre l’immagine di Siringa creando quello strumento che da allora porta il nome della ninfa.
Alla fine della sua vita Pan fu trasformato nella costellazione del Capricorno in quella metamorfosi chiamata catasterismo, ovvero un processo attraverso il quale si rendeva immortale un eroe, che veniva identificato in una stella o in costellazione.
Già presso i sumeri qualcuno aveva pensato di risolvere il problema rappresentato dalla mancanza di continuità nell’emettere fiato negli strumenti quali trombe o flauti; il suonatore doveva smettere di suonare per poter respirare, per cui si pensò di realizzare una sorta di serbatoio nel quale conservare l’aria necessaria per continuare a suonare e la soluzione fu trovata aggiungendo al flauto una sacca fatta di pelle di animali, quasi sempre capre o pecore, ermeticamente chiusa che veniva riempita soffiandoci dentro e che nei momenti di pausa respiratoria poteva offrire l’aria necessaria, comprimendo la sacca stessa, dando così continuità all’esecuzione.
In alcuni siti archeologici sono stati trovati reperti che suffragano questa ipotesi, mentre nella Bibbia nel libro di Daniele, scritto oltre 500 anni a.c. si legge che il re Nabucodonosor, nell’inaugurare una statua d’oro alta 60 cubiti e larga 6, aveva fatto radunare tutti i notabili e le genti d’ogni dove facendo dire agli araldi:
“È comandato questo: appena sentirete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa triangolare, dello strumento a corda, della zampogna e di ogni altro strumento musicale, inginocchiatevi con il viso a terra e adorate la statua d’oro che il re Nabucodonosor ha eretto. Chiunque non si inginocchi e non la adori sarà immediatamente gettato nella fornace ardente”
Anche nell’antico Egitto esistevano raffigurazioni si uno strumento noto come “Cornamusa di Tebe” risalente al 400 a.c. che era composto da una sacca sigillata di pelle di cane, mentre i romani che lo conoscevano come “Tibia utricularis”, gli attribuivano un’origine antica che ritenevano si si perdesse tra la Grecia o l’Etruria.
Un verso attribuito a Virgilio menziona “la zampogna dal suono dolce”, almeno una cinquantina di anni prima di Nerone, che pare fosse, come racconta Svetonio, un suonatore oltre che di flauto anche di quello strumento a fiato caldo ed anche di quello a mantice o a freddo, e pare che si esibisse con quello oltre che con la lira.
Sempre i romani la chiamavano anche zampogna dal latino symphonia, “accordo di suoni” parola derivata dal greco e con quel nome è ancora oggi nota in tutto il territorio italiano.
La zampogna si diffuse presto in tutta Europa, e risulta altresì presente in tutto il bacino Mediterraneo, in Iran, India e Cina.
Lo strumento consta oltre che della sacca di pelle di capra con il pelo all’interno, di una canna per introdurre aria nella stessa, soffiandoci ed una parte detta testale dalla quale escono normalmente quattro, in alcuni casi cinque, tubi di diversa lunghezza. Due melodiche ovvero strumento di canto modulabile mentre due o tre svolgono la funzione di bordone, cioè suonano una nota fissa, e sono normalmente dotate ognuna di una o due ance.
Oggi lo strumento viene incluso nella famiglia degli oboi con ancia doppia, e nel medioevo stava ad indicare il soprano della famiglia delle bombarde.
In alcune zone con la zampogna si suonano due ciaramelle, suonate o da una coppia di suonatori o in contemporanea dallo stesso suonatore talvolta con un cantante, in particolare in Lucania.
In Scozia lo strumento è considerato ancora oggi un patrimonio culturale proprio.
Alcuni storici credono che le cornamuse vi siano state portate con l’invasione delle Legioni Romane, quando ancora lo strumento era composto solo di semplici canne dotate di ance ma sprovviste di sacca. Altri sostengono che lo strumento sia arrivato via mare, dalle colonie delle tribù scozzesi dall’Irlanda.
Il primo testo che menziona la cornamusa in Scozia risale al 1396 ed è un resoconto della battaglia di North Inch of Perth, detta Battle of the Clans. La prima menzione della cornamusa come strumento musicale di guerra, risale al 1549 nella battaglia di Pinkie. I tubi hanno sostituito le trombe per aiutare ed ispirare gli Highlanders in battaglia, e si ritiene che a differenza delle trombe potessero essere uditi fino a 10 miglia di distanza. Per tale motivo furono considerate armi da guerra e solo nel 1785 fu abolito l’atto parlamentare che impediva di usare il kilt e trasportare cornamuse reati puniti penalmente.
In Francia a partire dal sedicesimo secolo si diffuse la cosiddetta “musette de cour”, piccola cornamusa familiare usata anche a corte strumento per il quale scrissero alcuni brani anche Bach e Mozart, e musette era una danza popolare che veniva ballata al suono della cornamusa.
In ogni luogo, ed in ogni tempo, la zampogna appare come uno strumento popolare legato alla vita semplice dei pastori e nel nostro paese essa è iconograficamente legata all’abbigliamento che i suonatori indossavano e che fanno parte del nostro DNA.
Sui presepi napoletani conservati a San Martino o nelle chiese più importanti, così come sulle statuine più o meno raffinate di San Gregorio Armeno, la figura dello zampognaro è caratterizzata dalle cioce indossate su spesse calze di lana, giacca di pelle di capra o di pecora, un mantello di lana pesante, un berretto con fiocco, ed i calzoni corti. Sono sempre in due, dei quali uno suona la zampogna ed il secondo, in genere più giovane, suona la ciaramella.
Normalmente gli zampognari arrivavano per la fine di novembre, in occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione e la novena, ovvero la ripetizione per nove giorni della musica devozionale che partiva da quel giorno, 29 novembre e durava fino al 7 dicembre, mentre una seconda novena, cioè la Novena del Bambino dedicata a Gesù veniva da loro eseguita nel periodo dal 16 al 24 dicembre.
La stessa cosa avveniva a Roma, dove gli zampognari che arrivavano il 25 novembre, venivano accolti nelle case dei fedeli che li rifocillavano con quello che si chiamava il cartoccio della padrona, che conteneva, oltre alla ricompensa in danaro, anche cibo e vino.
Normalmente il costo della novena era di 2 paoli, ovvero 20 baiocchi, e gli zampognari nella loro attività dell’intero periodo si dice che riuscissero a guadagnare fino a 40 o 50 scudi che permetteva loro di sopravvivere per sei sette mesi senza lavorare. Per comprendere, con uno scudo si potevano acquistare 2,5 kg di carne, ed una “fojetta”, cioè un litro di vino, costava 3 quattrini ovvero la quinta parte di un baiocco, che era un centesimo di scudo, e la rendita di un cardinale era intorno ai 4000 scudi annui.
Per potersi esibire gli zampognari, o come venivano chiamati allora “pifferai”, dovevano richiedere una autorizzazione che fu soppressa nel 1870 con l’avvento della capitale.
La zampogna continuò ad essere suonata in provincia durante le varie feste, da carnevale alle feste patronali ai matrimoni.
A Napoli e nel meridione d’Italia la tradizione non è mai morta, grazie anche al canto “Tu scendi dalle stelle” scritto da Sant’Alfonso Maria de Liguori verso la metà del settecento, che divenne il canto natalizio per eccellenza, e tuttora è la base dei canti di quegli artisti di strada.
Una mia studentessa mi raccontò che il padre continuava a far salire in casa gli zampognari a suonare dinanzi al presepe in presenza della famiglia, più volte durante la novena del bambino e che offriva ai suonatori una cifra mediamente di venti fino ad un massimo di cinquanta euro, non dissimile dai due paoli del settecento romano, e l’ultimo giorno offriva loro panettone e spumante come moderno “cartoccio della padrona”.
La stessa persona mi raccontò che aveva conosciuto un giovane contadino che durante il periodo delle feste svolgeva l’attività di suonatore di quello strumento, riuscendo a guadagnare fino a 5000 euro per stagione.
La pandemia di COVID ha interrotto quella tradizione per la sua famiglia.
Alcune famose canzonette napoletane hanno immortalato il fenomeno e mi piace ricordare sia la straziante memoria dell’emigrante, che all’avvicinarsi del Natale, scrive alla madre del suo desiderio di poter rivivere i suoi ricordi di quelle festività, chiedendo che alla tavola della festa sia aggiunto un piatto vuoto per lui che pensa ai figli dicendo nei versi della canzone “Lacreme napulitane” di Francesco Bongiovanni e Libero Bovio:
Comme vurría allummá dduje o tre biangale
Comme vurria sentì ‘nu zampugnaro
A ‘e ninne mieje facitele ‘o presebbio
E a tavula mettite ‘o piatto mio!
Facite, quann’è ‘a sera d’ ‘a Vigilia,
Comme si ‘mmiez’a vvuje stesse pur’io!
O ancora lo stupore e l’innamoramento del giovane avellinese che per la prima volta arriva a Napoli per suonare nelle case dei “Signori” immortalati nella canzone di Armando Gill “O zampugnare ‘nnammurat” nei versi:
Quanno jette pe vasà â signora ‘e mmane:
“Zitto”sentette ‘e dì “viene dimane”.
Cielo, e comme fuje doce
‘sta nuvena
ca ll’attaccaje cu ‘n’ata passione.
E se scurdaje ‘e ll’ammore ‘e Filumena
La “madelenie” di Proust ha costretto l’autore a riproporre in sette volumi le reazioni ad un profumo, mentre il suono di una zampogna è stato in grado di innescare un processo analogo racchiudibile forse nei versi di grandi artisti.
*già Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno