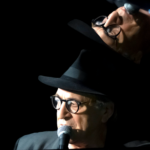Secondo incontro con gli autori de “La primavera fuori.31 scritti al tempo del Coronavirus”
Clotilde Baccari commenta i 31 scritti de “La primavera fuori”-
 Molto apprezzati i webinar organizzati dal direttore di salernonews24 e presidente dall’associazione culturale Contaminazioni, Claudia Izzo, dedicati al libro, La primavera fuori, 31 scritto al tempo del Coronavirus, (Il pendolo di Foucault) i cui proventi della vendita saranno devoluti all’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, di Salerno, reparto di Terapia Intensiva, con l’acquisto di un’attrezzatura specifica.
Molto apprezzati i webinar organizzati dal direttore di salernonews24 e presidente dall’associazione culturale Contaminazioni, Claudia Izzo, dedicati al libro, La primavera fuori, 31 scritto al tempo del Coronavirus, (Il pendolo di Foucault) i cui proventi della vendita saranno devoluti all’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, di Salerno, reparto di Terapia Intensiva, con l’acquisto di un’attrezzatura specifica. Durante il secondo webinar, visibile https://www.facebook.com/salernonews24notizie/videos/3779289388816869
Durante il secondo webinar, visibile https://www.facebook.com/salernonews24notizie/videos/3779289388816869
Molte le tematiche affrontate da Maria Gabriella Alfano nel suo racconto, l’amicizia, l’emigrazione interna dei giovani intellettuali, l’importanza della tradizione, la famiglia come cellula essenziale nella formazione dell’individuo e l’importanza della casa come unica opportunità di tenerci legati a noi stessi .
La memoria è il viatico per il ritorno al passato e a luoghi diversi da quello in cui ci troviamo. E’ questo il caso del protagonista del racconto che, attraverso sensazioni in un primo momento olfattive, poi anche legate al gusto, attraverso la memoria del sapore ritorna alla propria casa. La pastiera, il dono di un amico per soddisfare il sapore di casa, è il tramite per ritrovarsi , per ritornare alle tradizioni, a quello che si è stati. E la ricetta è una occasione per ricordare gli insegnamenti di chi ci ha preceduti. Il sapore, l’odore ci richiamano dolci ricordi, quello dell’infanzia, dell’adolescenza in un clima drammatico di isolamento e di solitudine in cui si aggira un nemico invisibile. L’autrice evidenzia il sentimento che è stato nutrito da buona parte degli italiani nella prima fase della pandemia: la coralità, la condivisione, il sentire insieme il dolore e trovare la maniera per alleggerirlo, (la pastiera dell’amico dono inaspettato) una maniera ben diversa dallo scoramento e dall’individualismo di cui si è vestita la seconda fase della pandemia. Il testo è scritto con dolcezza, con il cuore di mamma. Leggendo questo racconto mi viene da ricordare qualche verso della poesia di Mariangela Gualtieri secondo la quale in questo periodo di pandemia ognuno di noi dentro una frenata, imposta a tutti noi dal virus, sente di dover tornare indietro ,forse alle lentezze delle antiche antenate, delle madri
L’autore Giuseppe Esposito, rende ai lettori la sua storia per una riflessione sulla fragilità dell’uomo, sulla instabilità del destino umano di riconosciuta derivazione guicciadiniana.
“La vita non è null’altro che una tela sottile, basta un nonnulla a lacerarla”. Lo ha provato Giuseppe sulla propria pelle … In quella casa in cui per un tempo troppo breve aveva vissuto con lei una felicità grande e inattesa, era all’improvviso solo tutto silenzio, nella ” area immota, una sorte malvagia… trasformava la fede in rabbia e seminava una disperazione che andava ben oltre la morte e che neanche il tempo sarebbe riuscito a sanare. La luce dei ricordi per l’autore è l’antidoto al buio delle sue notti in cui percepisce ancora il senso di gelo e di vuoto di quando il respiro leggero di Lidia cessò. Una narrazione che suggella il contrasto tra la registrazione delle notti insonni e la lentezza della memoria, tra la pienezza della speranza di un miracolo e la disperazione del baratro, tra il vuoto del presente e il passato ricco di emozioni; un passato sopito non dimenticato, fatto di memorie, di voci e di volti. Un racconto di dolore che ratifica il vanificarsi anche della fede: ” A che serve piangere, disperarsi e gridare se lassù nessuno ti ascolta?”. In questo anno di morti, di buio, di vuoto e di silenzio ritornano le stesse sensazioni provate da Giuseppe, quelle condizioni di vuoto e di disperazione che testimoniano la fragilità umana.
Un percorso lungo le grandi epidemie della storia, quello di Daniele Magliano secondo un’attenta riflessione sulla necessità del distanziamento imposto dalla forza del virus che impone una condizione di isolamento e la domanda che l’autore si pone se la nostra società abbia saputo cogliere il vero senso della libertà. In questo racconto l’autore si sofferma sulla estrema fragilità dell’uomo; riflette sul senso di impotenza, sul timore e la paura suscitati verso se stessi e verso gli altri soprattutto verso i più fragili. Altra riflessione quella relativa ai limiti della società che ha manifestato la propria debolezza in quanto essa si presenta come una società globalizzata, fondata su interscambi di informazioni e sulla omologazione da cui è derivato l’ appiattimento del nostro vivere facendo perdere all’uomo comune la capacità istintiva di autodifesa, riducendo la possibilità di valorizzare la forza di ogni singolo. Esortazione dell’autore è la necessità di ripristinare l’abitudine al rispetto della persona e di quei valori che da essa derivano, per poter in tal modo intraprendere la via della rinascita.
Le foto di Armando Cerzosimo sono, al netto dell’esperienza esistenziale: la vita durante la pandemia. Con le sue fotografie l’autore dimostra la capacità del linguaggio fotografico di collegare gli spazi e le emozioni, di entrare nella realtà dispiegandola secondo l’orizzontale del suo negativo. Cerzosimo declina in pellicole versi e materie senza parole, consapevole di quanto l’immagine possegga una propria essenza, in questo caso la sofferenza. Una presa di coscienza spaziale in un momento in cui ogni tipo di coordinate si è dissolto nella difficoltà impellente della pandemia