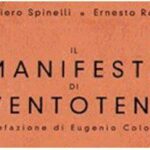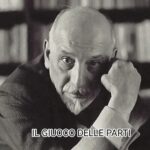Extra omnes
di Giuseppe Moesch*
Quando l’Arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, pronuncerà la famosa frase, le porte si chiuderanno alle spalle dei cardinali chiamati ad eleggere il nuovo Papa, ovvero il 267° successore di Pietro ed il successore di Francesco.
Quest’ultima precisazione non appaia peregrina: intorno ad essa infatti ruota l’intera complessa macchina elettorale.
Oltre il 50 % dei cristiani si riconosce nella religione cattolica per un totale di oltre 1,3 miliardi di fedeli. Non solo l’entità numerica, ma anche il ruolo che quei fedeli hanno giocato nel tempo e che ancora oggi giocano tra alti e bassi, descrive con chiarezza il clima di attesa di quella scelta.
Simon Pietro fu indicato da Gesù come erede e depositario della nuova espressione della antica religione biblica rivisitata dagli esseni e codificata nei Vangeli dei seguaci del Profeta figlio di Dio, l’essere perfettissimo creatore di tutto, omnisciente, e quindi egli stesso verità.
I concetti che erano stati diffusi da Mosè sotto forma di tavole della legge, furono definitivamente esplicitati da Gesù ai suoi discepoli nel sermone della montagna, che è la base dei principi su cui è fondata la chiesa cattolica; essere il successore di Pietro significa quindi perseguire quei valori e su di essi portare la verità nel mondo.
Sono passati duemila anni da quelle predicazioni e molte cose sono cambiate nella percezione della vita e dei comportamenti degli individui, e molto si è tentato di fare per adeguare i dettati evangelici alle mutate condizioni sociali, e molti scismi si sono creati proprio per tentare di affrontare le compatibilità tra la lettera e le mutate percezioni dei valori, con un conflitto tra la tradizione sulla quale si base l’intero sistema di credenze e le variazioni proposte.
Appare ovvio, quindi, che, se il nuovo Papa è il successore di Pietro non potrà che convenire su temi etici e morali quali fine vita, aborto, divorzio, ruoli nella società, politica e tutti gli altri in discussione nella società laica, anche se appaiono come espressione di una civiltà vecchia di due millenni.
Sappiamo anche che la chiesa ha giocato nel tempo un ruolo altro, di natura temporale, assumendo la leadership politica con confronti di ogni tipo, da potenza a potenza, rispetto agli altri potentati, e che ancora oggi esplica questa sua funzione sia nella forma che nella sostanza, basta rivedere la liturgia e la sontuosità formale dei funerali di Francesco, evento mediatico mondiale nel riconoscimento del ruolo che il Vaticano rappresenta potendo contare sul “gradimento” di un grandissimo numero di “followers”.
In un mondo caratterizzato da incertezze, paure ed instabilità, la chiesa ha saputo offrire un’immagine rassicurante e a riprendere un ruolo abbastanza rilevante rispetto a periodi di decrescita.
Negli ultimi cinquant’anni abbiamo assistito ad una successione di Papi che hanno incarnato i tentativi della Chiesa di adattarsi ai tempi o di tentare di mantenere salde le redini della fede, così, affianco a Papi populisti come Giovanni XXIII, Giovanni Paolo I e lo stesso Francesco, si sono alternate figure teologicamente più allineate ai valori tradizionali come Paolo VI e Benedetto XVI, oltre alla figura di Giovanni Paolo II, che apparve più come scelta funzionale politica in un periodo di gravi crisi mondiale.
Se il nuovo Papa dovrà essere il successore di Francesco, allora bisognerà ipotizzare che la Chiesa dovrà abbandonare una parte delle rigidità legate al dettato biblico ed evangelico per adattarsi sempre più ad un mondo social, ad un mondo del consenso e dei “like”.
È questo il range nel quale si dovrà iscrivere la scelta dei 133 porporati chiamati ad esprimersi, nella Cappella Sistina, sotto l’affresco michelangiolesco, a nome di tutta la collettività cattolica, anche se vi sono altri 117 cardinali non elettori per raggiunti limiti di età; questa strana norma è stata prevista forse ipotizzando l’istupidimento umano allo scadere del 79° anno, anche in quest’epoca on cui la vita umana si è allungata significativamente. Ma la cosa più singolare è che la maggior parte degli ultimi Papi ha raggiunto età ragguardevoli e gli stessi anziani porporati esclusi partecipano a dibattiti pubblici con intelligenza, arguzia e cognizione di causa, e la Chiesa, nell’espressione di Francesco, aborre l’idea degli anziani come scarto.
È evidente che i dieci concistori del defunto Papa, e la creazione di ben 149 nuovi cardinali, dei quali 108 attuali elettori abbiano rappresentato un tentativo riuscito di modificare l’assetto del conclave non solo in termini di età, quanto in termini di chi li aveva nominati, così da rendere più omogeneo il gruppo degli elettori.
È interessante notare che tra le motivazioni dell’aumento del numero di cardinali vi era quella della rappresentatività di tutte le aree della terra, sorta di inserimento di forme di democrazia, che però è solo di facciata: è come se si fosse creato una sorta di zoo in cui tutte le specie animali fossero presenti in esposizione, ma senza tener conto della numerosità della specie, in quanto aspetto non rilevante per le funzioni loro affidate. Uno vale uno, quindi se non sei presente vali zero, come succede per i non cardinali delle diocesi di importanti città italiane quali Milano, Venezia, Torino, Bologna e Palermo, sicuramente più significative dal punto di vista della numerosità di fedeli rispetto alla Mongolia o a Papua.
Non è la prima volta che la Chiesa si trova ad affrontare tali problemi, basti pensare all’elezione dell’eremita Pietro da Morrone, elevato al soglio pontificio con il nome di Celestino V°, che tentò di riportare il cattolicesimo ai valori della tradizione e dimessosi per l’impossibilità di realizzare i suoi obiettivi, fu incarcerato e fatto morire, con almeno il beneplacito del suo successore Bonifacio VIII°. È interessante notare che all’epoca della sua elezione vi erano solo 11 cardinali ed il nuovo Papa creò, in un solo concistoro ben 13 nuovi cardinali, forse con la stessa logica dei nostri giorni, ma non riuscì ad impedire che il cardinale Caetani fosse eletto come Bonifacio VIII°.
Il potere temporale ha sempre condizionato le scelte dei dirigenti della Chiesa e non appaia bizzarra o folcloristica la pubblicazione dell’immagine di Trump vestito da Papa, consapevole quell’uomo dell’enorme potere di quella figura sui destini dell’umanità.
Già prima del conclave i cardinali durante le riunioni della Congregazioni hanno tentato di delineare un identikit del futuro pontefice sollecitando nel contempo, per il futuro, un ruolo più collegiale della gestione del potere, sul modello delle democrazie più avanzate, pensando ad una visione meno verticistica dell’autorità, forse con tale auspicio scegliendo la via politica rispetto a quella tradizionale.
Tra qualche giorno sapremo quale scelta sarà stata fatta, solo però dopo che la frase extra omnes sarà risuonata nell’anticamera della Sistina.
*già Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno
Fotografia Pixabay Licence