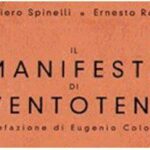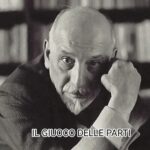Il Racconto della Domenica: Professore per caso
di Giuseppe Moesch*
Preparare l’esame di Matematica Generale era considerato l’impegno più gravoso del primo anno di economia; il programma era vastissimo e veniva studiato sul testo del professor Carlo Ciliberto, futuro Rettore, allievo di Renato Caccioppoli e Carlo Miranda, lo stesso testo che il docente utilizzava nella facoltà di ingegneria, dove però era diviso in due parti con quella relativa alla geometria svolta separatamente.
Avevamo seguito tutte le lezioni e le esercitazioni, queste ultime tenute da una giovanissima assistente, dolcissima nei modi, quasi una monaca laica, ma durissima agli esami.
Ricordo ancora la tensione nell’ultimo mese, non tanto per lo studio nella dimostrazione dei teoremi, quanto per la risoluzione degli integrali; avevamo escogitato un metodo di incentivazione assai efficace. Studiavamo in tre Claudio, Arturo ed io e ognuno di noi ne proponeva uno e la sfida era di svolgerlo nel minor tempo, mettendo in palio una sigaretta.
Eravamo a principalmente a casa di Claudio o di Arturo, essendo casa mia la più disagevole per il numero di fratelli e sorelle che turbavano la concentrazione.
La madre di Claudio chiedeva che il figlio fosse a casa per motivi di controllo anche se noi preferivamo andare da Arturo, dove eravamo praticamente soli, essendo presente solo il padre vedovo, che spesso era fuori e comunque non si intrometteva nelle nostre faccende.
Era un uomo singolare, realizzava piccole invenzioni attraverso attività di bricolage e aveva avuto due figli a distanza di qualche anno l’uno dall’altro, con il primo, laureato, se non ricordo male, in Scienze Politiche. che aveva intrapreso la carriera diplomatica, mentre Arturo era più propenso a vivere la vita in maniera, diciamo così, più vivace.
Era fuori corso; lo avevamo conosciuto in facoltà quando saltuariamente seguiva le lezioni di matematica e subito facemmo amicizia.
Durante i mesi primaverili, appena le giornate divenivano più calde, quando allo scoccare della campanella dell’una eravamo liberi, andavamo con la sua scassatissima Renault a Marechiaro, ci facevamo traghettare, dai marinai che sostavano alla fine della scala che portava al Lido delle Rose, sugli scogli di Punta nera sotto Villa Malatesta.
Lo scoglione, come veniva anche nominato, era tappezzato di cozze, piccolissime per la stagione, che lo ricoprivano in buona parte, e che sarebbero quasi scomparse nei mesi seguenti, razziate dai bagnanti che sarebbero arrivati al migliorare delle condizioni del tempo.
A marzo il sole era già abbastanza caldo e noi andavamo per il piacere di restare in riva al mare a crogiolarci ed abbronzarci, consumando una piccola colazione, che aveva acquistato da Cicciotto. Era un buco una specie di grotta sulla discesa che portava al lido delle Rose, con un banco sul quale erano esposte le sperlunghe cariche di peperoni, melanzane, fritti e ripassati con i pomodori, le polpette, i porpetielli affogati, la cianfotta, tutto quello che avrebbe potuto essere infilato nel cuzzetiell do palatone, ovvero nel culo del filone di pane cafone, croccantissimo, svuotato della mollica, che sarebbe diventato il tappo di quel corposo, imponente e sontuoso banchetto che ci avrebbe ristorato dopo poco più di un’ora.
Cicciotto vendeva anche taralli ‘nzogna e pepe, carichi di mandorle, e se qualcuno voleva, poteva arrangiarsi sedendo in due massimo tre persone, al tavolino che si trovava tra il banco di esposizione, il frigorifero e l’ingresso di quell’antro dove si trovava la minuscola cucina.
I piatti che il corpulento proprietario preparava erano ovviamente a base di pesce che comprava dai pescatori che giungevano nel porticciolo sottostante, o anche i frutti di mare, che qualche giovane sommozzatore ante litteram, pescava sotto la Gaiola o sulle chiane quasi affioranti, ricche di cozze, dove anche io d’estate mi rifornivo insieme a Panzarotto, al secolo Vittorio giovane assistente di macelleria, soprannominato così per l’estrema magrezza.
Quindi qualche piatto di vermicelli o di linguine e qualche pescetiello di paranza, tra questi sempre presenti le alici, apparivano come d’incanto a soddisfare il palato di chi preferiva la sostanza alla forma dei più rinomati concorrenti tra cui all’epoca ‘A Fenetella e Rosiello, ma anche più costosi.
Una volta, giunti allo scoglione, ci mettevamo in costume da bagno, anche se specialmente fino alla fine d’aprile non ci immergevamo nell’acqua che valutavamo di tanto in tanto con la punta di un piede, ma trovavamo gelida: non c’era spiaggia per cui il mare sprofondava subito di parecchi metri e quindi il sole non era in grado di riscaldarlo.
Un giorno mentre eravamo a prendere il sole, vedemmo arrivare, trasportati dal solito Caronte, un gruppo di allegri giovani, una mezza dozzina tra uomini e donne, che appena sbarcati e denudati, si tuffarono in acqua.
Non so bene se sia stato più forte la componente di orgoglio partenopeo, o la convinzione che ormai l’acqua si andava riscaldando, che decisi di seguirli e senza pensarci troppo mi tuffai anch’io.
La reazione del mio corpo fu immediata: un miliardo di aghi mi stava colpendo su ogni singolo centimetro quadrato, o almeno fu questa la sensazione, e fu una frazione di secondo quella che impiegai per schizzare fiori dall’acqua, mentre quei temerari giocavano a sommergersi l’un l’altro ea spruzzarsi acqua come facevamo d’estate.
Ci dissero che erano danesi e solo qualche anno dopo, durante un viaggio fatto in piena estate in quel Paese, compresi il perché del loro entusiasmo, quando su una spiaggia di fronte alle isole Frisoni settentrionali, ebbi modo di vedere i cestoni coperti per difendersi dal vento, nei quali prendevano il sole, osai mettere i piedi in acqua che trovai della stessa temperatura di quel lontano giorno a Napoli.
Arturo era un giocatore nato: non era affetto da ludopatia, era un professionista che campava con il poker. Era questa la ragione per la quale le sue performance universitarie non erano da considerarsi esemplari.
Il poker gli permetteva di mantenere la macchina, di comprare le sigarette, di comprare vestiti, fare dei viaggi, senza gravare sulle finanze familiari.
Non strafaceva, era un metodico, che ruotava su tre o quattro locali, se si vuole, bische, dove era noto e rispettato come un giocatore serio ed abile ed era capace di capire gli uomini contro cui giocava, senza emotività ma con lucida freddezza, e vinceva.
Sullo scoglione di Punta Nera, steso un asciugamano a terra, tiravamo fuori le carte francesi e cominciavamo a giocare a ramino o a scala quaranta, a punti. Ovvero, per tutto il tempo che passavamo insieme oltre a chiacchierare del più e del meno, rendevamo interessante le partite e la somma algebrica dei punti totalizzati da ambedue formavano il totale a debito di uno nei confronti dell’altro. Il pagamento non avveniva in moneta corrente cioè in lire italiane dell’epoca, bensì in cozze, le più grosse disponibili in loco, ma non quelle presenti sullo scoglio, ma quelle sommerse sulla parte non emergente.
L’impegno era gravoso proprio per le condizioni climatiche ed era il danno derivante dalla raccolta che pesava maggiormente, oltre alla beffa dell’aver perso la partita per quel giorno.
La casa di Arturo, in prossimità di Piazza San Pasquale, era ovviamente un luogo di passaggio per gli amici che abitavano nel quartiere o che frequentavano la facoltà di Via Caracciolo e tra questi ricordo Roberto e Gianpiero.
Il primo apparteneva ad una famiglia cosiddetta importante: in primis per il nonno megasideralgalattico manager bancario, che successivamente sarebbe stato coinvolto in un grosso scandalo, mentre tra altri esponenti della famiglia venivano annoverati stimati professionisti ed un importante professore.
Roberto era un vulcano di idee ed iniziative, pronto allo scherzo ed all’ironia, di grande intelligenza, intuitivo, e di ottima preparazione, che sarebbe cresciuta quando decise, o forse decisero, che avrebbe dovuto studiare all’estero. Nel frattempo aveva cominciato a seguire i primi corsi extra universitari che venivano offerti anche a Napoli, dove per lo più la tradizione tendeva a sviluppare il mondo giuridico e poco quello tecnico economico. Fu proprio lui che mi suggerì di iscrivermi ad un corso che veniva offerto da un Centro Studi che tentava di introdurre i primi rudimenti di economia nelle Facoltà di Ingegneria, dove la sola materia di quel tipo era l’Estimo.
A quel tempo non avrei immaginato che quel suggerimento avrebbe segnato la mia vita, e quando l’anno successivo mi iscrissi diedi avvio alla mia carriera di ricercatore e di professore.
Il passaggio di quegli e di altri amici, segnavano altrettante interruzioni nello studio, come anche le provvidenziali spremute d’arance, o i frullati che il padre di Arturo ci portava, lieto per il fatto che il figlio avesse finalmente deciso di studiare.
Ma non erano solo queste le interruzioni che segnavano la nostra attività di studenti; eravamo, chi più chi meno, tutti fumatori ed eravamo seduti immersi in una nuvola di fumo, circondati da posaceneri colme di mozziconi di sigarette, e pacchetti vuoti, e proprio quei pacchetti innescarono una sorta di tic collettivo che consisteva nel separare la parte interna dei contenitori nelle due componenti la carta e la sottile striscia di alluminio che garantiva alle sigarette di restare asciutte.
L’operazione era meccanica, praticamente automatica quasi una specie di tic: finite le sigarette nel pacchetto, il privilegiato di turno estraeva dalla scatola il foglio bicomponente, e con grande pazienza, mentre ascoltava il lettore di turno, iniziava a scollare i due rettangoli separando quindi l’alluminio dalla carta che finiva nel posacenere, spesso bruciata, diversivo nel diversivo, mentre il foglietto d’alluminio veniva steso accuratamente e posto infine sulla pila degli altri ottenuti nei giorni precedenti.
A quell’epoca gli accendini erano prevalentemente a benzina, che veniva venduta in fialette dal tabaccaio e che riempivano i serbatoi degli zippo entrati in uso nel dopoguerra, che avevano però il difetto di conferire al fumo uno sgradevole sentore di benzina. C’erano pochi esemplari a gas, una marca, la Ronson, in particolare, spopolava sul mercato, anche se la maggior parte dei fumatori usavano ancora i vecchi fiammiferi. Ce n’erano di diversa natura cioè zolfanelli, svedesi e cerini, questi ultimi fatti da piccoli bastoncini di carta cerata arrotolati con una capocchia di materiale combustibile, che sfregati su una superficie ruvida prendevano fuoco, ed erano quelli che usavamo per completare il nostro gioco pirotecnico, con l’ausilio della carta stagnola che avevamo ricavato di pacchetti di sigarette.
L’operazione consisteva nel riunire tre cerini inserendone un quarto a testa in giù, avvolgere le capocchie dei tre con la carta stagnola, allargando i tre steli fa ormare un tripode al centro del quale era presente il quarto con la parte incendiabile scoperta. Appoggiato il tripode in un posacenere, era sufficiente accendere il cerino fuoriuscente che incendiandosi provocava il calore necessario da trasmettere alle teste chiuse nella carta stagnola provocando un scoppio che faceva sollevare il tripode come una specie di razzo.
Ovviamente la migliore esecuzione dell’artefatto faceva si che il missile raggiungesse altezze maggiori, ed era vanto dell’esecutore il traguardo raggiunto.
Con il tempo cominciammo a migliorare il prodotto specializzandoci ed uno dei miglioramenti fu sicuramente quello di inserire nella testata non solo i tre cerini, ma anche una piccola dose di sostanza incendiaria, ricavata sbriciolando le capocchie di altri cerini. L’effetto esplosivo era assai più significativo anche se i rischi erano crescenti in quanto il missile tendeva a prendere traiettorie imprevedibili.
Novelli Von Braun, era quello il nome dello scienziato tedesco che in America portava avanti il programma missilistico di quel Paese dopo l’esperienza sulle V2 svolta per il governo Hitleriano a Peenemünde, sull’isola di Usedom, dove la Wermacht sperimentava la cosiddetta arma definita, decidemmo di seguire le logiche di quei pionieri e pensammo di costruire dei veri e propri missili.
La costruzione avveniva attraverso una fase di costruzione della fusoliera che consisteva nell’arrotolare più fogli di carta stagnola intorno all’anima di una panna bic ottenendo così un tubicino che veniva riempito con le capocchie sbriciolate dei cerini e chiuso ad una estremità, veniva armato con il solito sistema del cerino capovolto a cui si dava fuoco.
I risultati furono stupefacenti perché in effetti l’oggetto si alzava in volo e raggiungeva altezze assai più significative, ma sempre con l’impossibilità di controllarne la traiettoria.
Arrivammo alla penultima invenzione attraverso l’applicazione di piccole alette che potevano mantenere l’assetto, e poggiammo il manufatto su una sorta di rampa di lancio che posizionammo però sul davanzale della finestra dello studio. L’esperimento dette buoni risultati e lo costatammo anche dal plauso che una ragazza che abitava nel palazzo di fronte ci tributò quando lo vide partire, dando così vita alla fase finale del progetto, ovvero il missile multistadio per raggiungere la finestra della dirimpettaia.
Costruimmo tre tubi incastrati l’uno nell’altro con il solito sistema di accensione e le alette direzionali, e una base ampia a sufficienza per il nuovo ordigno.
Grande emozione al momento del battesimo che avvenne con perfetta esecuzione salvo che le alette del proiettile, urtarono sulla base di lancio e fecero deviare la traiettoria dell’oggetto impazzito. Prima si diresse verso l’interno ed il soffitto dell’appartamento per poi rimbalzare su sé tesso e ritornare verso la finestra dando fuoco alle tende di materiale sintetico.pixabay
La cosa più difficile non fu quella di spegnere l’incendio bensì come spiegare al padre di Arturo perché non ci fossero più le tende in quella stanza.
*già professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno