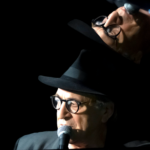LIBERA, intervista ad Anna Garofalo, Coordinamento Provinciale Salerno
“Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie” è nata il 25 marzo 1995 con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere, legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di circa 1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base. Territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità.
Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero della solidarietà sociale.
 Ne parliamo con Anna Garofalo, referente dell’istruzione e formazione presso il Coordinamento Provinciale di Libera a Salerno.
Ne parliamo con Anna Garofalo, referente dell’istruzione e formazione presso il Coordinamento Provinciale di Libera a Salerno.
L’associazione Libera si radica e sviluppa sull’intero territorio Salernitano, attraverso il Coordinamento Provinciale di Salerno, esattamente di cosa si occupa? Qual è l’obiettivo principale?
Oggi Libera conta, in ogni regione, i coordinamenti regionali; nelle province in cui non c’è, ci sono i coordinamenti provinciali e i presidi territoriali che sono il cuore dell’associazione. Quando Libera nasce a Salerno come coordinamento, esistono delle realtà associative, singoli individui e gruppi che nella loro vita associativa, nel loro impegno personale, fanno riferimento a questa associazione.
Il coordinamento di Libera prova a mettere insieme tutte queste diverse realtà e fa in modo che queste riescano a dialogare tra loro verso obiettivi condivisi.
 Qual è secondo lei, il modo più efficace per far conoscere “Libera”? Quanto possono essere utili i social media nel suo lavoro?
Qual è secondo lei, il modo più efficace per far conoscere “Libera”? Quanto possono essere utili i social media nel suo lavoro?
Libera è una realtà che nasce ufficialmente nel 1995, si costituisce come “network di associazioni”, in fatti il titolo completo della nostra realtà associativa è “LIBERA-ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE”.
Abbiamo quindi notato un grande sviluppo sulla conoscenza della nostra realtà associativa, proprio con l’avvento dei media, ma insieme ai media come strumenti di comunicazione, è stato molto importante il lavoro che Libera ha fatto sui territori e l’impegno che sui territori ha profuso, nel tempo, rispetto alle questioni fondamentali in cui l’associazione crde, per esempio la memoria delle vittime innocenti delle mafie, la formazione interna, esterna con le scuole e le università e il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Queste realtà lavoravano in maniera strutturata, grazie alla volontà di singoli, realtà associative e gruppi.
Come e quando nasce il suo desiderio di operare, coordinare e partecipare con grande costanza e dedizione, all’interno dell’associazione Libera?
Ti ringrazio per questa domanda personale. Ho iniziato a far parte di questa realtà associativa quando intrapresi l’esperienza di amministratrice presso il comune del mio paese, Pagani. Lì ero Assessore alle Politiche Giovanili e all’Istruzione e, insieme ad altri due assessori donne, l’Assessore alla Cultura e l’Assessore alle Politiche Sociali, insieme al nostro responsabile del progetto “Sicurezza e Legalità”, mettemmo insieme un programma che coinvolse i tre settori e le tematiche di Libera. In quella occasione ho cnosciuto per la prima volta questa realtà.
La mia esperienza amministrativa finì, per una serie di vicende politiche e anche personali, però io ho continuato a “fare Libera” e a sentirmi Libera”, facendo l’insegnante, perché proprio il settore della formazione ci garantisce come docenti un’alternativa ad un sistema scolastico che non sapeva cogliere le tematiche fondamentali di Libera.Ho lavorato prima con alunni più giovani delle medie e poi con i ragazzi delle superiori, dove ho continuato il mio lavoro con una consapevolezza maggiore, data dal l’esperienza.
Libera, per me, è stata una condizione di vita, un modo di essere oltre che di operare e posso dire che non è stato sempre facile, non siamo stati sempre compresi e quando abbiamo iniziato a porre delle questioni serie, che andavano ad incidere su poteri forti e a mettere in luce situazioni di criticità, anche nel mio comune, abbiamo cominciato a dare un “po’ fastidio”, lì abbiamo capito che Libera a quel punto, doveva organizzare e strutturare una rete solida, questo perché la forza era ed è nella rete, ed è questo il lavoro in cui siamo impegnati molto in tutte le realtà.
Come pensa che si debbano avvicinare i ragazzi alla lotta alla mafia? Qual è il messaggio che lei da docente ha cercato di diffondere?
Questo è un discorso che nel tempo ci ha messo anche in crisi, perché all’interno della scuola, spesso le esperienze di educazione civica, di cittadinanza e costituzione, hanno messo in luce varie difficoltà che la scuola aveva. Stavamo cioè preparando dei futuri cittadini, anche spesso molto preparati nei contenuti delle singole discipline, ma generalmente incapaci di rapportarsi al mondo esterno e vedevamo all’interno delle scuole, delle relazioni, le conflittualità e tutti i problemi che conosciamo anche oggi e che addirittura si sono acutizzati, per cui mi sono ritrovata spesso a parlare di responsabilità, dell’impegno ad essere cittadini nel rispetto della costituzione.
Uno dei grandi veicoli è stato il far capire ai ragazzi che conoscere la Costituzione e praticarla non erano due pratiche separate. Attraverso esperienze dirette, come per esempio parlare e spiegare loro “lo statuto degli studenti e delle studentesse” che è la loro carta nazionale, i ragazzi si sono resi conto di quali fossero non solo i loro doveri, ma anche i loro diritti ed hanno cominciato a capire che questo rispetto “delle leggi giuste” è una delle questioni fondamentali per sentirsi parte di un tutto, di una realtà.
Poi, attraverso il valore della memoria delle vittime innocenti delle mafie, con le stragi di Capaci e Via D’Amelio si è aperto un fronte e la società civile ha preso finalmente coscienza che le mafie esistono, che si poteva parlare di mafia, che quelle stragi erano dovute anche a responsabilità politiche, sappiamo infatti che c’è un processo aperto su questo e che eravamo tutti responsabili e questo modo di pensare, di ricordare e di commemorare è ridiventato per noi fondamentale per la memoria civile, soprattutto attraverso la “GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI” che dal 2017 è diventata anche giornata nazionale.
Noi come Libera insegnamo ai ragazzi che quello non è solo un ricordo, una sterile commemorazione, noi celebriamo la vita di quelle persone, tutto quello che rappresentano e soprattutto quello che avrebbero voluto o potuto fare nella loro vita se non fossero morte. Quindi abbiamo sempre abbinato la conoscenza di queste tematiche con l’uso pratico, per diffondere la cultura della legalità.
Quali letture consiglierebbe ai ragazzi per comprendere quello che Libera sta facendo per sostenere la lotta contro le mafie?
Per i ragazzi c’è una bella letteratura che potrei consigliare; cito” LA CLASSE DEI BANCHI VUOTI” di Ciotti e Possentini, “LA COSTIUZIONE RACCONTATA AI BAMBINI” di Colombo, mentre per gli adulti c’è allo stesso modo una grande letteratura che negli ultimi anni è diventata più ampia. In particolare ci sono questi studi che stanno facendo all’Università di Salerno, con il professore Marcello
Ravveduto che si occupa di Public and Digital History e che apre mondi rispetto ai giovani che ancora non avevamo compreso il fenomeno; quindi consiglio il suo libro “LO SPETTACOLO DELLA MAFIA”.
Inoltre a proposito di questo testo e della memoria volendo collegare tutto sotto un’unica realtà, ricordo il premio dedicato a Marcello Torre. Noi come Libera incontriamo sempre le scuole superiori, non solo della nostra città, ma anche quelle scuole che fanno percorsi di educazione alla legalità, quindi quelle scuole definite “difficili”, questo grazie al professore Ravveduto e alla mediazione dei volontari di Libera. Si apre così un dibattito su come l’immaginario mafioso appare attraverso i social, attraverso la musica, attraverso la pubblicità ed è una cosa che è di un interesse unico. La gestione, l’analisi, la conoscenza e l’interpretazione dell’utilizzo dei social attraverso studiosi è fondamentale per la diffusione ai nostri giovani di tematiche che ci stanno a cuore, altrimenti rischiamo di fare vuota retorica, facciamo anche le commemorazioni, ci commuoviamo, però poi in realtà non cambiamo le cose.