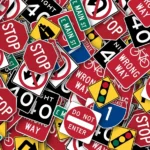Fine pena mai
-di Michele Bartolo-
Nel nostro ordinamento costituzionale, l’esecuzione della pena è regolata dal principio espresso nell’art. 27 della Carta, il cui terzo comma prevede che l’espiazione della pena abbia uno scopo rieducativo, debba tendere cioè al recupero del reo alla vita sociale. Premesso quanto sopra, la domanda che dobbiamo porci è se una legislazione di emergenza, che da provvisoria diventa organica al nostro sistema normativo, possa confliggere con i principi costituzionali regolatori della materia.
Mi riferisco, nello specifico, agli articoli 22 c.p, 4 bis e 58 ter della l. 354/1975, che hanno introdotto nel nostro ordinamento il cd. ergastolo ostativo, ovvero la normativizzazione di una serie di preclusioni e divieti in merito ai benefici penitenziari, tali da trasformare il carcere a vita in un vero e proprio fine pena mai. Nessuna possibilità, quindi, di permessi premio, misure alternative alla detenzione o assegnazione di lavoro all’esterno.
L’aspetto più discutibile di tale normativa, in effetti, è la compresenza di ulteriori modifiche legislative, partorite da scelte di politica criminale di volta in volta determinate dall’emotività del momento, che hanno di fatto ampliato il numero e la portata dei reati ricompresi nella disposizione.
Come accade sempre nel caso di successioni di leggi, carenti di coordinamento tra loro, la conseguenza è che viene comminata la identica severa punizione per ipotesi delittuose diverse. Invero, la ratio costituzionalmente dubbia di tale istituto è la presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato che non collabora con la giustizia. La scelta, cioè, del condannato a pena detentiva perpetua di non collaborare con la giustizia viene di fatto equiparata alla mancata redenzione ed alla continuità di rapporti organici con l’organizzazione criminale, che impedisce l’accesso a qualsivoglia forma di beneficio penitenziario.
A prescindere dalla scelta del legislatore di voler pretendere dal condannato il rilascio di dichiarazioni autoincriminanti ovvero la denuncia di terzi soggetti, al fine di ottenere un alleggerimento della propria posizione carceraria, proprio come avvenuto nel periodo del terrorismo o per i reati di mafia, ciò che deve valutarsi come ingiusto è l’elargire benefici a chi collabora e pene e sanzioni più severe a chi non collabora, valutando quindi questo unico elemento per discriminare chi merita un trattamento penitenziario più favorevole e chi viceversa deve essere recluso a vita.
Forse sarebbe il caso di valutare anche altri aspetti nel percorso di espiazione della pena da parte del condannato che potrebbero comunque essere indici di avvenuto distacco dall’ambiente criminale, senza che questo necessariamente comporti l’obbligo di collaborazione con l’autorità giudiziaria. In tale senso, è già intervenuta una recente pronuncia della Corte Costituzionale , la n. 253 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis della l. 354 del 1975 nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416 bis del codice penale (associazione a delinquere di tipo mafioso e similari) e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia (..) allorchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti (..)”, estendendo poi la portata dell’intervento correttivo anche ai detenuti per delitti diversi da quelli di cui all’art. 416 bis. Ancora, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è occupata dell’ergastolo ostativo nel caso Viola contro Italia, ritenendo l’istituto in contrasto con l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo intitolato “Proibizione della tortura”: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
La Corte quindi dice che “la collaborazione con la giustizia può offrire ai condannati all’ergastolo ostativo una strada per ottenere questi benefici” ma anche che la mancanza di collaborazione non deriva sempre da una scelta libera e volontaria di adesione ai valori criminali e di mantenimento di legami con l’organizzazione di appartenenza, come già affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 306/1993. Con queste premesse, la Corte costituzionale dovrà adesso pronunciarsi nuovamente sulla legittimità nel suo complesso dell’unica pena nel nostro ordinamento che preclude ogni possibile liberazione condizionale e non potrà non farlo nel solco dei precedenti giurisprudenziali richiamati.
E’ sicuramente auspicabile, in tal senso, che venga eliminata ogni forma di automatismo, restituendo al magistrato di sorveglianza la possibilità di giudicare caso per caso e di verificare in concreto se la mancata collaborazione del condannato possa essere giustificata e superata dalla concomitanza di altri fattori che, viceversa, consentano una rideterminazione della pena in senso favorevole per il recluso ed in armonia con il dettato costituzionale.