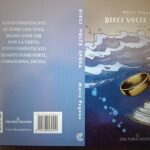Portella della Ginestra, 1 Maggio 1947. E’ strage di Stato?
di Claudia Izzo
1 Maggio 1947, siamo a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, località Portella della Ginestra, così chiamata per i fiori selvatici che vi nascono, nota localmente come Purtelja e Jinestrës.
Qui i contadini si radunarono, come ogni anno, per festeggiare il 1 Maggio, La festa dei lavoratori, con loro le famiglie e gli animali. Sono circa 1500 persone. A mancare sono i dirigenti di partito. Il luogo viene scelto perché lì, Nicola Barbato, una delle figure simbolo del socialismo italiano, che fin dal tempo dei Fasci lì parlava alla folla da un podio naturale che fu in seguito battezzato “Sasso di Barbato”. Questa giornata era anche un modo per festeggiare la recente vittoria del Blocco del Popolo. Con l’alleanza tra i socialisti di Nenni e i comunisti di Togliatti alle elezioni dell’assemblea regionale siciliana, la coalizione PSI-PCI aveva conquistato 29 rappresentanti su 90 (con il 32% circa dei voti) contro i 21 della DC (crollata al 20% circa).
La manifestazione, incentrata sulla sperata riforma agraria, era stata preceduta nell’ottobre del 1944 dall’occupazione delle terre incolte che venne legalizzata dal Ministro dell’Agricoltura Fausto Gullo. Questi, infatti, favorendo gli agricoltori rispetto ai proprietari, con alcuni decreti permise l’occupazione dei terreni non utilizzati, imponendo una diversa ripartizione dei raccolti. Tutto ciò si allontanava dalle consuetudini fino ad allora vigenti in Sicilia e fu visto come primo passo verso l’alterazione degli equilibri politici della regione, gestiti anche dalla mafia.
Voleva essere un giorno di festa ma sfocerà nel sangue con una strage che porterà ad 11 morti e 24 feriti, secondo i dati ufficiali, per poi scoprire che i feriti saranno molti di più. –
C’è chi sostiene che dal sangue di quella strage nacque la Prima Repubblica, come dal sangue della strage di Capaci e via D’Amelio in cui persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, tre uomini della scorta e il Giudice Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta, nacque la Seconda Repubblica.
Il luogo in questione, Portella della Ginestra, è diventato un sacrario, un Memoriale, con le pietre disposte in cerchio che portano i nomi delle vittime, restaurato poi e riconosciuto l’anno scorso dalla commissione Regionale Antimafia come “bene simbolo dell’intera nazione” con l’avvio della dichiarazione d’interesse culturale. Il tutto è avvenuto nel 2023 nella Sala Pier Santi Mattarella, ucciso dalla Mafia, grazie alla Soprintendente di Palermo Selima Giuliano, figlia di Boris, capo della Squadra Mobile di Palermo, ucciso da Cosa Nostra nel 1979, proprio l’anno di inizio dell’opera.
In quel 1947 in merito alla strage, tante sono le denunce che furono respinte, le prove ignorate, quelle segretate. Eppure nel radiogramma inviato al Governo subito dopo il massacro si legge: “azione terroristica devesi attribuire elementi reazionari in combutta con la mafia, movente politico“. Accanto alla mafia e al banditismo si colloca un corpo paramilitare: per molti lo stesso schema usato nelle stragi di Capaci e via D’Amelio. Se infatti nei libri di Storia leggiamo di 11 morti e 21 feriti, si è scoperto nel tempo che i numeri non coincidono: risulterebbero un’altra ventina di referti di persone non elencate, ferite da schegge metalliche, una di esse morta per tetano. Oltre ai feriti colpiti da granate e bombe a mano, in seguito a perizie effettuate sui superstiti, molti quel giorno verranno raggiunti da schegge di proiettili sparati da fucili calibro 9, in esclusiva dotazione alla Polizia.
Portella della Ginestra diventa un problema per il PC che vede saltare gli equilibri del dopoguerra, per la DC per cui l’episodio deve restare una questione siciliana per cui Mario Scelba, Ministro dell’Interno, riduce il tutto ad una questione locale adducendo tutta la responsabilità al famigerato bandito Salvatore Giuliano, avverso ai comunisti, tenendo in ombra la volontà dei poteri mafiosi e delle forze reazionarie di mantenere i vecchi equilibri nel nuovo quadro politico e istituzionale nato dopo la Seconda Guerra Mondiale. L’ombra più cupa che si abbatte sullo scenario è che ad essere invischiati nel massacro non fossero solo Giuliano e la mafia.
Di Portella delle Ginestre è difficile parlare. Il maestro del Realismo Luchino Visconti è in Sicilia in quel periodo e intende parlare dell’accaduto nel suo “La terra trema”, ha testimonianze e materiale, ma i fondi vengono bloccati a Roma. Il film uscirà con lo stesso titolo grazie al Direttore dell’Osservatore Romano, ma sarà girato ad Acitrezza e diventerà i Malavoglia di Verga. Nel 1962 Francesco Rosi gira “Salvatore Giuliano”, riproponendo la verità ufficiale con la banda di Giuliano unica responsabile e con il bandito in impermeabile bianco, presente solo nella scena con il binocolo in mano. Nel 2003 arriva “Segreto di Stato” di Paolo Benvenuti che ruota intorno alla figura di Gustavo Pisciotta, cugino e uomo di Salvatore Giuliano, prima infiltrato della Polizia, dopo la strage, dei carabinieri. Dotato di un lasciapassare con l’autorizzazione della Polizia a guidare mezzi e portare armi, sarà lui a consegnare il cugino Giuliano alla Polizia. Morirà in carcere anni dopo.
La Storia seguirà il suo corso con i contadini che ottengono i poderi della Riforma Agraria e la Mafia che mette le mani sulle città tra appalti e speculazione edilizia. E lo Stato?