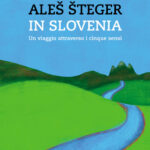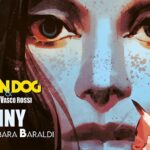Elezioni del 1953: fu davvero Legge truffa?
di Pierre De Filippo-
Pietro Nenni, segretario del Partito socialista, lo aveva detto immediatamente che la nuova legge elettorale, approvata in marzo a pochi mesi dalle elezioni che avrebbero aperto la II legislatura, era una truffa.
Una truffa perché concedeva alla coalizione che avrebbe ottenuto il 50% più uno dei voti il 65% dei seggi: un classico premio di maggioranza. Ma Nenni storceva il naso perché sapeva che, in quel contesto, l’unica coalizione che avesse potuto raggiungere quella percentuale sarebbe stata quella “centrista”, della Dc e dei suoi alleati laici, repubblicani, socialdemocratici e liberali.
La lotta fu aspra, la propaganda intensa: si parlò di stravolgimento dell’ordine costituito, di tradimento degli ideali costituzionali, di “regime”.
Di nuovo i corsi ed i ricorsi storici di vichiana memoria: quando non sappiamo a che santo votarci, ci appelliamo al pericolo democratico. Non c’era ieri, nel 1953, e non c’è nemmeno oggi, nel 2022.
La Democrazia cristiana veniva da cinque anni di intensa attività amministrativa, in cui aveva rafforzato la propria posizione sui territori attraverso le parrocchie, i campanili.
Le riforme erano state approvate, i soldi del Piano Marshall erano arrivati e l’ingresso nella Nato – il cosiddetto Patto atlantico – era stato ufficializzato già nel 1949.
Ma le incognite e le tensioni, per la DC, non erano poche: le elezioni amministrative del 1952 avevano rappresentato un forte campanello d’allarme, non solo in termini di perdita di consensi ma anche a causa del raffreddamento dei rapporti tra Alcide De Gasperi ed il Vaticano.
De Gasperi aveva capito che aldilà del Tevere erano molto più anticomunisti che antifascisti e che non avrebbero disdegnato un accordo con monarchici e missini pur di non far vincere la sinistra.
Il secco “no” di De Gasperi alla candidatura di Luigi Sturzo gli aveva, praticamente, reso impossibile ogni comunicazione con Pio XII, con tanto di ufficiale strascico polemico.
Non solo questo: la Guerra fredda – che aveva rischiato di diventare calda con la guerra in Corea – iniziava, anche se molto lentamente, il suo processo di disgelo.
La morte di Stalin a marzo del ‘53 rappresentò per il comunismo italiano un’occasione: sfruttare la spinta emozionale ma distanziarsi e rendersi più autonomi dalla opprimente ideologia rossa.
Il voto utile – questo De Gasperi lo sapeva bene – non c’era più (perché i dollari del Piano Marshall erano arrivati e perché i comunisti facevano meno paura); per questo motivo, per ottenere stabilità, aveva fatto approvare la “legge truffa”.
Dall’altra parte della barricata, dopo la coalizione del ’48, comunisti e socialisti avevano capito che sarebbe stato per loro più produttivo andare da soli. Avrebbero gestito meglio le proprie truppe, avrebbero raccolto tutti i voti degli indecisi ed avrebbero fornito all’elettore di sinistra più sfumature tra le quali scegliere.
Nenni, oltretutto, accusato di aver eccessivamente appiattito le posizioni del suo partito su quelle comuniste, aveva subito l’onta dell’espulsione del suo partito dalla “internazionale socialista”. Perciò si scagliava con veemenza contro la “legge truffa”.
Questione di prospettive.
Le elezioni videro la coalizione centrista mancare il quorum che le avrebbe consentito di godere del premio per poche migliaia di voti ed il progetto degasperiano esaurirsi.
A sinistra, i comunisti doppiano i socialisti in termini di voti, affermandosi come i principali e più autorevoli rappresentanti del mondo operaio.
Col senno di poi, si può dire che le elezioni del 1953 rappresentano una fine ed un inizio. La fine è certamente quella dell’epopea di Alcide De Gasperi, che lascia il governo nell’estate del ’53 e muore in quella del ’54; l’inizio è rappresentato da due trasformazioni importanti: l’apertura a sinistra ed il disgelo costituzionale.