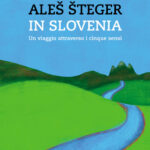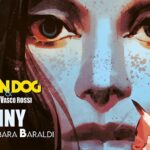L’ambiente urbano in Italia tra luci ed ombre
Il Rapporto ISPRA 2018 analizza città e aree metropolitane- di Vincenzo Iommazzo-
Un campione di 120 città e 14 aree metropolitane italiane sono state prese in considerazione dal rapporto ISPRA-SNPA 2018 con un particolare focus sulle esperienze innovative. Positiva la crescita della sharing mobility che nel giro di tre anni (2015-2017) aumenta più del doppio il numero delle vetture in condivisione. Delle 48 mila unità messe su strada lo scorso anno, gli utenti hanno utilizzato biciclette per l’83%, per il restante automobili (16%) e scooter.
Dolori, invece, per i superamenti del PM10 nelle città italiane: i dati preliminari, aggiornati al 10 dicembre 2018, mostrano valori oltre la norma in 19 aree urbane con gli 80 superamenti di Brescia maglia nera, mentre Viterbo si mostra virtuosa, non avendo mai oltrepassato il limite. Per fortuna, non mancano segnali positivi per la significativa tendenza alla riduzione dei livelli di emissione del PM10 primario, quello direttamente emesso dal riscaldamento domestico, dai trasporti, dalle industrie e da alcuni fenomeni naturali, che si riduce di quasi il venti per cento nei dieci anni dal 2005 al 2015.
Per 190 mila abitanti nelle città del campione analizzato, invece, pericolo di frane e alluvioni, la cui probabilità supera di gran lunga la media nazionale. Le città mostrano di correre ai ripari: negli ultimi diciotto anni sono stati finanziati interventi contro il dissesto in 120 comuni per un ammontare complessivo che supera il miliardo e mezzo di euro e di circa 2 miliardi nelle città metropolitane. I Comuni con il maggior numero di interventi portati a termine sono Lucca, Terni, Messina e Ravenna. Genova, Milano e Firenze hanno complessivamente accumulato 643 milioni di stanziamenti, ma con basse percentuali di interventi già conclusi.
Non si evidenzia una significativa inversione di tendenza per quanto riguarda la continua perdita di terreno nei Comuni italiani che oltre a un cospicuo numero di ettari di terreno vedono sparire i principali servizi ecosistemici (supporto alla vita, approvvigionamento di risorse, regolazione dell’ecosistema, valori culturali e ricreativi), valutati nel quinquennio scorso tra i 215 e i 270 milioni di euro, con in testa Roma che perde un valore attorno ai 28 milioni di euro. A livello di Città metropolitane, nel 2017 Napoli e Milano presentano la percentuale di suolo consumato più alta, intorno al 33%, mentre Palermo la percentuale più bassa con appena il sei per cento.
Voragini si aprono di continuo in particolare a Roma dove, solo negli ultimi 10 mesi se ne sono contate 136. Seguono a ruota Napoli, Cagliari e Palermo. Tendenzialmente sono le città del Centro-Sud quelle maggiormente interessate dal fenomeno che risulta contenuto, invece, nel nord Italia dove, comunque, negli ultimi tempi si registra un aumento dei casi.
Buoni i risultati per quanto riguarda lo stato chimico delle acque: il 40% delle città prese in considerazione ha i corpi idrici di pertinenza in stato “Buono” e solo il 13% in stato ”Non buono”. Nel 2017, il 95% delle acque di balneazione italiane (marine, lacustri e fluviali) si posiziona in classe eccellente e buona, ma l’uno per cento rimane di livello qualitativo molto inferiore.
La maggioranza dei Comuni indagati ha una disponibilità di aree verdi pubbliche pro capite compresa fra i 10 e i 30 m2/ab. e le tipologie di verde più diffuse sono quello attrezzato e quello storico, seguite dalle aree boschive e dal verde incolto. Rimane molto scarsa anche la pianificazione del verde: appena 10 Comuni hanno approvato un Piano del verde, a segnalare la difficoltà delle amministrazioni censite a riconoscere il verde quale elemento strategico di resilienza urbana, nonostante le continue sollecitazioni in tal senso delle principali associazioni ambientaliste. Una luce in fondo al tunnel si è accesa nel 2018, con la nascita del primo elenco nazionale degli alberi monumentali: in 60 comuni sui 120 analizzati è stato censito almeno un albero monumentale per un totale di 413 segnalazioni.
“Dal Rapporto emerge un quadro con luci ed ombre, chiosa Ornella Capezzuto, presidente di WWF Napoli, ma con la chiara indicazione dei settori urbani (inquinamento atmosferico e difesa del suolo per esempio) in cui c’è molto da lavorare, soprattutto a livello di programmazione ben studiata e pluriennale, abbandonando la logica dispendiosa e improduttiva degli interventi in emergenza, che si è rivelata costume generale da troppo tempo a questa parte”.